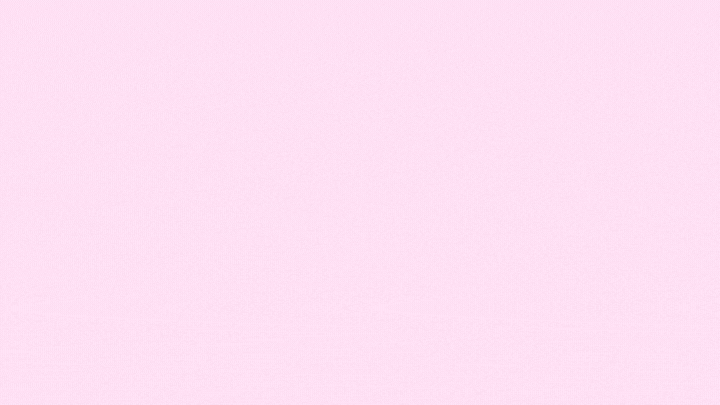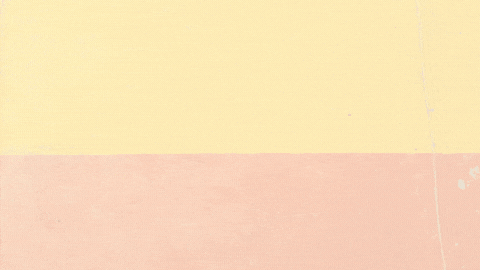Al tema che lega il treno alla fine della vita, Rotaie contrappone uno spunto alternativo: quello del treno come strumento per il ritorno alla vita e per il riscatto. I tempi sono ancora quelli del muto – siamo nel 1929, e il sonoro è alle porte – quando Mario Camerini, regista tra i più attenti di cronaca vera, immagina una stanza in cui due giovani hanno deciso di uccidersi bevendo del veleno, fermati nel loro proposito grazie a un treno che passa sotto la finestra. Le vibrazioni sulle rotaie del convoglio fanno rovesciare il bicchiere col veleno e i due ritrovano la forza di vivere e di sognare fuggendo a Sanremo.
Per anni si è parlato di Rotaie (il titolo, di per sé, è emblematico), come del film che ha concretizzato il «miracolo del treno» e, parallelamente, la nascita di quella che la critica definirà come la corrente del «camerinismo», incentrata sul mondo delle piccole cose e della piccola gente.
«La prima parte – ha scritto Paolo Mereghetti – ambientata in una camera d’albergo, si rifà al Kammerspiel tedesco, con qualche inserto espressionista (il bicchiere con la pozione mortale che occupa tutto lo schermo, il gioco delle luci e delle ombre che però vengono realmente dagli esterni urbani); la seconda, sanremese, ricorda invece la commedia brillante americana, anticipando la tendenza successiva del regista (anche in termini di “garbata” satira sociale); l’ultima, che recupera l’etica del lavoro e la realtà positiva della città industriale (senza l’angoscia né l’esaltazione delle avanguardie), si riaggancia al cinema sovietico, con una composizione finale che ricorda il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo».
Espressionismo e drammaticità si risolvono efficacemente nella scena da cui la storia prende le mosse. Subito dopo la caduta del bicchiere, l’uomo si affaccia al balcone, da dove vede poi il treno sfilare nella notte. E le luci della città, le insegne pubblicitarie diventano richiamo alla vita, a cui gli amanti si riaffacciano improvvisamente decidendo di tentare un altro tipo di fuga: a Sanremo, e naturalmente per ferrovia.
L’idea del treno come simbolo della fuga, era già un topos letterario affermato quando Camerini girò Rotaie. Basti pensare a Il fu Mattia Pascal, che Luigi Pirandello diede alle stampe nel 1903, in cui il protagonista va a Montecarlo, dove vince in modo strepitoso e al ritorno consegna a un treno la svolta della sua vita che lo allontana dalla famiglia, convinta della sua morte.
In Rotaie, la presenza del treno risolutore si manifesta anche nel finale. Quando, oltre alle frequenti scene di viaggio di cui si compone la storia (anche con ritmiche geometrie di binari in montaggio rapido), Camerini inserisce un espediente narrativo che dà la svolta alla scelta dei due giovani. Imparata la lezione dopo l’esperienza borghese al Grand Hotel, in loro soccorso giunge una locomotiva che spunta da dietro una siepe, sbuffando fumo bianco. È un richiamo netto e irrinunciabile per la coppia, che riprende la strada del ritorno, verso una vita “normale”, o quantomeno più semplice. A conferma di questo, i due si vedranno quindi nello scompartimento di terza classe mentre socializzano con una famigliola, in un quadretto che preannuncia la loro conversione esistenziale e sociale. Facile immaginare, a questo punto, che le rotaie in piena velocità inquadrate dal regista abbiano finalmente la direzione giusta, quella verso una vita fondata sull’amore familiare e sul lavoro. Miracoli dei treni e della ferrovia.
Rotaie (Italia, 1929)
Regia e sceneggiatura: Mario Camerini
Soggetto: Corrado D’Errico
Fotografia: Ubaldo Arata
Scenografia: Umberto Torri, Daniele Crespi, Vittorio Cafiero, Angelo Canevari
Musica: Marcello Lattes
Interpreti: Käthe von Nagy, Maurizio D’Ancora, Daniele Crespi, Aldo Moschino, Carola Pia Lotti
Produzione: SACIA/Nero Film
Origine: Italia/Germania
B/N
__________________
Roberto Scanarotti, giornalista e scrittore, ha pubblicato Treno e cinema. Percorsi paralleli (Le Mani editore, 1997), Aghi, Macachi e Marmotte – Dizionario semiserio per viaggiare in treno (ecedizioni, 2009), Destinazione immaginario – Andata e ritorno nell’universo simbolico della ferrovia (ilmiolibro.it, 2012) e Ultra vendeva noccioline (2013). Treno e cinema sono amici da sempre. Per l’esattezza dal 28 dicembre 1895, quando i fratelli Lumière – a loro insaputa – firmarono l’atto di nascita della settima arte portando in scena proprio un’inquietante locomotiva con alcune carrozze al traino. Da quel momento in poi, dopo letterati, poeti e pittori, anche i cineasti furono attratti dal fascino della ferrovia, e non ci volle molto tempo prima che il treno diventasse un celebrato protagonista degli schermi. Roberto Scanarotti svelerà miti e riti della ferrovia su celluloide, attraverso una serie di segnalazioni focalizzate su rail-movie e dintorni. Buon viaggio sui binari dell’immaginazione, dunque, anche ai pendolari che viaggiano ogni giorno su quelli reali e sono quindi poco sensibili alle suggestioni poetiche del mondo dei treni. Ma tant’è: parafrasando Bogart, bisogna pur ricordarsi che “è la ferrovia bellezza, e tu non ci puoi fare niente!”.